 Il ritmo dei cambiamenti sistemici in quell'entità indivisibile, conosciuta come Palestina/Israele, è così rapido da superare, quasi, la nostra capacità di tenersene al corrente. La campagna deliberata, e sistematica, per cacciare i palestinesi dal Paese, nel 1948, è stata rapidamente dimenticata; la triste situazione di più di 700mila profughi è divenuta qualcosa di invisibile, che neanche si pone come problema. Al contrario, un Israele impavido, europeo e “socialista” è diventato il beniamino di tutti, sinistra radicale compresa, eclissando completamente la pulizia etnica che aveva reso possibile creare lo Stato.Allo stesso modo, l'occupazione da parte di Israele, nel 1967, della Cisgiordania, di Gerusalemme Est e di Gaza è rimasta un problema virtuale, che nemmeno si è posto, fino allo scoppio della prima Intifada, alla fine del 1987. L'unica parte del conflitto ad apparire sul radar pubblico è stata l'equazione fra palestinesi e terrorismo. Fino all'inizio dei negoziati di Oslo, nel 1993, persino il nominare il termine “occupazione”, per non dire quello “palestinesi” vi avrebbe fatto etichettare come antisemita; ancora oggi, in Israele, queste parole si usano di rado. Persino quando il conflitto, se non l'Occupazione di per sé, è diventata una questione internazionale, Israele ha dominato l'ambito, importantissimo, delle pubbliche relazioni. Il ragionamento più efficace, contro la lotta palestinese, è l'idea, assai diffusa, che Arafat, a Camp David, abbia rifiutato la “generosa offerta” di Ehud Barak. Nell'interpretazione scompaiono i fatti reali: che non vi è mai stata una “generosa offerta”, e che, persino se Barak avesse proposto il 95 per cento dei Territori Occupati - come Olmert ha di recente “offerto” il 93 per cento -, uno Stato palestinese costituirebbe poco più di un bantustan sudafricano tronco, economicamente non autosufficiente, su meno del 20 per cento della Palestina storica. Tutto ciò che resta è la ridemonizzazione di Arafat. Che Sharon abbia in seguito imprigionato il presidente palestinese in una stanza buia di un quartier generale demolito, eliminandolo politicamente, e, credo, pure fisicamente, non ha in pratica suscitato opposizioni, e neppure critiche, nella comunità internazionale.Tuttavia, uno sforzo deciso da parte di gruppi della società civile in varie parti del mondo – organizzazioni per i diritti umani e politici, chiese e gruppi ebraici critici, sindacati, intellettuali, e persino alcune figure politiche, in Israele come all'estero – è riuscita, più o meno negli ultimi dieci anni - a far pervenire l'Occupazione allo status di un problema globale. Non appena il concetto di Occupazione ha preso piede, ciononostante, l'espandersi febbrile di “fatti sul terreno” da parte di Israele ha reso superato il termine. La legge internazionale, infatti, definisce l'occupazione “una situazione militare temporanea”. L'aver istituito più di 200 colonie ed avamposti per soli ebrei nei Territori Occupati, organizzati in sette grandi “blocchi”, tutti legati inestricabilmente all'Israele propriamente detta da una rete massiccia di autostrade solo per israeliani, e, alla fine, la Barriera di Separazione, l'hanno resa permanente. Un indivisibile sistema di Israele, non più temporaneo o fondata sulla sicurezza, si è esteso fra il Mediterraneo e il Giordano. Chi di noi era risolutamente deciso a vedere ha scorto, davanti ai propri occhi, il vero: che ci si impegnasse o meno per una soluzione a due stati, l'Occupazione è stata trasformata in un sistema di apartheid permanente. Finora, è una realtà di fatto. Se il “Processo di Annapolis” funziona in base al piano israeliano, lo diventerà anche di diritto, venduto abilmente come una “soluzione a due stati”, e approvato da un leader collaborazionista palestinese.Nella realtà, tuttavia, Annapolis, non è importante. Israele sa che né i palestinesi, né la società civile internazionale accetteranno l'apartheid. La sua funzione è quella che si voleva avessero tutti gli altri “processi politici” degli ultimi quattro decenni: procrastinare ogni soluzione che richiederebbe da Israele concessioni significative, accordandole intanto la copertura politica ed il tempo per creare, sul terreno, fatti irreversibili. La “Occupazione” da parte di Israele ha oltrepassato l'apartheid – termine che è divenuto superato quasi nel momento stesso in cui lo si è iniziato ad accettare, fra grandi proteste e strepiti. Ciò che si è sviluppato davanti ai nostri occhi – qualcosa che avremmo dovuto vedere, ma per il quale non avevamo termini di riferimento – è un sistema di stoccaggio, una situazione statica svuotata di ogni contenuto politico. “Quel che Israele ha costruito”, sostiene Naomi Klein, nel suo nuovo e straordinario libro, The Shock Doctrine,“È un sistema... una rete di recinti a cielo aperto per milioni di persone, classificati come umanità eccedente.... I palestinesi non sono l'unico popolo al mondo ad essere stato categorizzato in questo modo.... Lo scartare dal 25 al 60 per cento della popolazione è stato il marchio di fabbrica della crociata intrapresa dalla Scuola [di Economia] di Chicago.... In Sud Africa, in Russia e a New Orleans, i ricchi costruiscono intorno a sé dei muri. Israele ha condotto ancora più avanti questo processo di rifiuto: ha costruito muri intorno ai poveri pericolosi” (p. 442).I fatti israeliani sul terreno non sono altro che l'esprimere in modo fisico una linea che cerca di depoliticizzare, e quindi di normalizzare, il controllo esercitato. Lo scontro israelo-palestinese non è presentato come un conflitto che ha parti in causa ed una dinamica politica. È descritto, invece, come una “guerra al terrorismo”, una lotta con un fenomeno che elimina – o indica come irrilevante – ogni riferimento all'occupazione, che Israele ufficialmente nega di imporre. Dal momento che il “terrorismo”, con lo “scontro di civilizzazioni” che ne è alla base, è dipinto come un “dato” evidente e perpetuo, assume la forma di un problema che non è tale, di uno status quo (termine israeliano ufficiale per la sua politica verso i palestinesi), immune ad ogni soluzione e/o ad ogni processo negoziale. I “terroristi” e chi è a loro associato – carcerati, immigranti illegali, baraccati, poveri, le vittime malcontente della “repressione delle sommosse”, chi aderisce a religioni, ideologie o culture “malvagie”, per non citarne che alcuni – sono considerati come strutture fisse, da affrontare, anziché che come persone: se li si considerassero come esseri umani, si cercherebbero risposte ai loro reclami, alle loro necessità ed ai loro diritti. Una volta che si è scelto di affrontarli, la soluzione logica, e penultima, al problema globale divengono le prigioni, fra cui sono comprese le residenze coatte vaste come Gaza.“Tenere in stoccaggio” è l'espressione migliore, anche se la più cupa, per quanto Israele sta attuando per i palestinesi dei Territori Occupati. È qualcosa di peggiore, per diversi motivi, dei bantustan sudafricani dell'era dell'apartheid. Le dieci “patrie”, economicamente non autosufficienti, istituite dal Sud Africa per la maggioranza africana nera sullo 11 per cento soltanto del territorio del Paese erano, certo, un tipo di stoccaggio. Avevano lo scopo di fornire al Sud Africa manodopera a basso prezzo, liberandola della popolazione nera; questo rendeva possibile una “democrazia” dominata da europei. Questo è precisamente ciò a cui Israele mira - tramite un bantustan palestinese che comprende all'incirca il 15 per cento della Palestina storica -, ma con un limite cruciale: ai lavoratori palestinesi non sarà permesso recarsi in Israele. Avendo scoperto una manodopera più a buon mercato - circa 300mial lavoratori stranieri, importati da Cina, Filippine, Thailandia, Romania ed Africa Occidentale, con l'aggiunta dei propri cittadini arabi, mizrachi, etiopi, russi e dell'Europa dell'Est – Israele può permettersi di rinchiudere fuori i palestinesi, impedendo loro, nel contempo, di avere un'economia autosufficiente che sia la loro, legata senza ostacoli ai Paesi arabi circostanti. Da ogni punto di vista – storico, culturale, politico ed economico – i palestinesi sono stati definiti come una “umanità in sovrappiù”; l'unica cosa da fare con loro resta lo stoccarli, atto che la comunità internazionale, che se ne interessa, pare voler permettere ad Israele.Dal momento che lo stoccaggio è un problema globale, e che Israele ne presenta, pionieristicamente, un modello, quel che avviene ai palestinesi dovrebbe preoccupare chiunque. Potrebbe costituire un crimine interamente nuovo contro l'umanità, e come tale, dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione internazionale dei tribunali del mondo, così come lo sono altre gigantesche violazioni dei diritti umani. In questo senso, la “Occupazione” israeliana ha implicazioni che oltrepassano di gran lunga un conflitto localizzato fra due popoli. Se Israele può confezionare ed esportare la propria, pluristratificata, Matrice di Controllo – un sistema di repressione permanente, che combina un'amministrazione kafkiana, leggi e sistemi di pianificazione con forme apertamente coercitive di controllo su una popolazione definita, intrappolata da comunità chiuse ostili (in questo caso, le colonie), muri e ostacoli al movimento di vario tipo - allora, come scrive semplicemente la Klein, ogni Paese somiglierà ad Israele/Palestina: “Una parte sembra Israele; l'altra sembra Gaza”. In altre parole, una Palestina Globale.Questo contribuisce molto a spiegare perché Israele non si cura di intraprendere processi di pace genuini, o di risolvere il conflitto con i palestinesi. Stoccandoli, ottiene il meglio da entrambi i mondi: completa libertà di espandere le colonie e di esercitare il controllo, senza mai dover fare compromessi, come lo richiederebbe una soluzione politica. Questo, analogamente, spiega perché la comunità internazionale permetta ad Israele di farla franca. Anziché presentare alla comunità internazionale problemi spinosi che devono essere risolti – violazioni dei diritti umani, della legge internazionale e di ripetute risoluzioni dell'ONU, per tacere delle implicazioni del conflitto medesimo sulla politica e l'economia internazionale – è considerato invece come chi fornisce un servizio di gran valore: lo sviluppo di un modello con il quale le “popolazioni eccedenti”, ovunque, possono essere controllate, gestite e contenute.Israele, allora, è completamente sincronizzata alla logica, economica e militare, del capitalismo globale, e per questo la si premia generosamente. Il nostro errore, incoraggiato da termini come “conflitto”, “occupazione” e “apartheid”, è considerare il controllo israeliano dei palestinesi come un problema politico che si deve risolvere. Sarà invece “risolto” quando i palestinesi saranno fatti “scomparire” – esattamente come avveniva sotto i regimi militari, in America Latina. Dov Weisglass, l'architetto del “ritiro” da Gaza del governo Sharon, aveva detto qualcosa del genere, in un'intervista rivelatrice (“The Big Freeze”, Ha'aretz Magazine, 8 ottobre 2004):“Il piano di ritiro è il conservante del principio sequenziale. È la bottiglia di formaldeide in cui mettere la formula del presidente [che Israele può mantenere i “blocchi” di colonie, compresa la Grande Gerusalemme] in modo che si conservi per un tempo molto prolungato. Il ritiro è, nei fatti, formaldeide. Fornisce la quantità di formaldeide necessaria perché non ci sia un processo politico con i palestinesi”.Haaretz: “Sta sostenendo, quindi, che avete scambiato la strategia di un accordo ad interim a lungo termine, con quella di una situazione ad interim, sempre a lungo termine?”“L'espressione americana è: “parcheggiare in modo opportuno”. Il piano di ritiro rende possibile ad Israele di parcheggiare in modo opportuno, in una situazione ad interim che ci distanzia quanto più possibile dalla pressione politica. Legittima il nostro assunto, che non vi è processo negoziale, con i palestinesi. Si tratta della decisione di fare il minimo possibile, per mantenere la nostra situazione politica. La decisione si dimostra valida. Rende possibile agli americani andare dalla comunità internazionale, che è in fermento e ribolle, e dire loro: “Cosa volete.” In più, trasferisce l'iniziativa nelle nostre mani. Obbliga il mondo ad occuparsi della nostra idea, dello scenario che abbiamo scritto...”.“Tenere in stoccaggio” è il più netto dei concetti politici: rappresenta il de-politicizzare la repressione, il trasformare un problema politico di prim'ordine in un non-problema, in una situazione spiacevole ma inevitabile, di cui il miglior modo di occuparsi è mediante il soccorso, la carità ed i programmi umanitari, unitamente agli schemi per lo “sviluppo” economico. È un vicolo cieco, un “dato”, per il quale non vi è a disposizione alcun rimedio. Non è questo, evidentemente, il caso, e non possiamo lasciarlo presentare in questo modo. Il tenere in stoccaggio è una linea politica che sorge dagli interessi particolari dei più potenti. Che noi adoperiamo questa espressione, pertanto, dovrebbe mirare a “dare un nome alla cosa” per comprenderla, allo scopo di combatterla e sconfiggerla. Israele, di nuovo, fornisce un esempio istruttivo (e incoraggiante). Perché, malgrado il suo potere quasi illimitato e privo di alcun controllo su ogni elemento della vita palestinese – ciò che comprende il sostegno attivo degli USA, dell'Europa e di gran parte della comunità internazionale, fra cui alcuni regimi arabi e musulmani -, non è riuscita a rendere inamovibili ne' l'apartheid, ne' lo stoccaggio. La resistenza palestinese continua, con il sostegno di popoli arabi e del più vasto ambito musulmano, di settori significativi della società civile internazionale e del campo della pace, critico, di Israele. L'effetto destabilizzante del conflitto sul sistema internazionale non fa che crescere, ed è possibile che, alla fine, obblighi la comunità internazionale ad intervenire. Ne' gli israeliani, ne' gli americani (con la complicità europea) sono in grado, malgrado il loro potere soverchiante, di imporre a forza il risultato a cui ambiscono.Il termine “stoccare”, pertanto, pur riferendosi ad un fenomeno reale, ha anche il significato di preavvertire. Dobbiamo procedere nel nostro sforzo di far finire l'Occupazione israeliana, anche se questo significa, alla fine, creare una Palestina/Israele autentica, o una più ampia confederazione regionale, piuttosto che una soluzione di apartheid-con-due-stati o uno stoccaggio vero e proprio. Guardare alla Palestina come ad un microcosmo di una più vasta realtà globale di stoccaggio ci rende capaci di identificare in modo più efficace gli elementi che compaiono altrove e di comprendere il modello che Israele sviluppa, per opporvisi meglio. In ogni caso, il nostro linguaggio, e l'analisi che questo genera, devono non solo essere onesti e privi di inutili riguardi: devono anche mantenersi al corrente delle intenzioni politiche e dei “fatti sul terreno”, che si espandono sempre più rapidamente.
Il ritmo dei cambiamenti sistemici in quell'entità indivisibile, conosciuta come Palestina/Israele, è così rapido da superare, quasi, la nostra capacità di tenersene al corrente. La campagna deliberata, e sistematica, per cacciare i palestinesi dal Paese, nel 1948, è stata rapidamente dimenticata; la triste situazione di più di 700mila profughi è divenuta qualcosa di invisibile, che neanche si pone come problema. Al contrario, un Israele impavido, europeo e “socialista” è diventato il beniamino di tutti, sinistra radicale compresa, eclissando completamente la pulizia etnica che aveva reso possibile creare lo Stato.Allo stesso modo, l'occupazione da parte di Israele, nel 1967, della Cisgiordania, di Gerusalemme Est e di Gaza è rimasta un problema virtuale, che nemmeno si è posto, fino allo scoppio della prima Intifada, alla fine del 1987. L'unica parte del conflitto ad apparire sul radar pubblico è stata l'equazione fra palestinesi e terrorismo. Fino all'inizio dei negoziati di Oslo, nel 1993, persino il nominare il termine “occupazione”, per non dire quello “palestinesi” vi avrebbe fatto etichettare come antisemita; ancora oggi, in Israele, queste parole si usano di rado. Persino quando il conflitto, se non l'Occupazione di per sé, è diventata una questione internazionale, Israele ha dominato l'ambito, importantissimo, delle pubbliche relazioni. Il ragionamento più efficace, contro la lotta palestinese, è l'idea, assai diffusa, che Arafat, a Camp David, abbia rifiutato la “generosa offerta” di Ehud Barak. Nell'interpretazione scompaiono i fatti reali: che non vi è mai stata una “generosa offerta”, e che, persino se Barak avesse proposto il 95 per cento dei Territori Occupati - come Olmert ha di recente “offerto” il 93 per cento -, uno Stato palestinese costituirebbe poco più di un bantustan sudafricano tronco, economicamente non autosufficiente, su meno del 20 per cento della Palestina storica. Tutto ciò che resta è la ridemonizzazione di Arafat. Che Sharon abbia in seguito imprigionato il presidente palestinese in una stanza buia di un quartier generale demolito, eliminandolo politicamente, e, credo, pure fisicamente, non ha in pratica suscitato opposizioni, e neppure critiche, nella comunità internazionale.Tuttavia, uno sforzo deciso da parte di gruppi della società civile in varie parti del mondo – organizzazioni per i diritti umani e politici, chiese e gruppi ebraici critici, sindacati, intellettuali, e persino alcune figure politiche, in Israele come all'estero – è riuscita, più o meno negli ultimi dieci anni - a far pervenire l'Occupazione allo status di un problema globale. Non appena il concetto di Occupazione ha preso piede, ciononostante, l'espandersi febbrile di “fatti sul terreno” da parte di Israele ha reso superato il termine. La legge internazionale, infatti, definisce l'occupazione “una situazione militare temporanea”. L'aver istituito più di 200 colonie ed avamposti per soli ebrei nei Territori Occupati, organizzati in sette grandi “blocchi”, tutti legati inestricabilmente all'Israele propriamente detta da una rete massiccia di autostrade solo per israeliani, e, alla fine, la Barriera di Separazione, l'hanno resa permanente. Un indivisibile sistema di Israele, non più temporaneo o fondata sulla sicurezza, si è esteso fra il Mediterraneo e il Giordano. Chi di noi era risolutamente deciso a vedere ha scorto, davanti ai propri occhi, il vero: che ci si impegnasse o meno per una soluzione a due stati, l'Occupazione è stata trasformata in un sistema di apartheid permanente. Finora, è una realtà di fatto. Se il “Processo di Annapolis” funziona in base al piano israeliano, lo diventerà anche di diritto, venduto abilmente come una “soluzione a due stati”, e approvato da un leader collaborazionista palestinese.Nella realtà, tuttavia, Annapolis, non è importante. Israele sa che né i palestinesi, né la società civile internazionale accetteranno l'apartheid. La sua funzione è quella che si voleva avessero tutti gli altri “processi politici” degli ultimi quattro decenni: procrastinare ogni soluzione che richiederebbe da Israele concessioni significative, accordandole intanto la copertura politica ed il tempo per creare, sul terreno, fatti irreversibili. La “Occupazione” da parte di Israele ha oltrepassato l'apartheid – termine che è divenuto superato quasi nel momento stesso in cui lo si è iniziato ad accettare, fra grandi proteste e strepiti. Ciò che si è sviluppato davanti ai nostri occhi – qualcosa che avremmo dovuto vedere, ma per il quale non avevamo termini di riferimento – è un sistema di stoccaggio, una situazione statica svuotata di ogni contenuto politico. “Quel che Israele ha costruito”, sostiene Naomi Klein, nel suo nuovo e straordinario libro, The Shock Doctrine,“È un sistema... una rete di recinti a cielo aperto per milioni di persone, classificati come umanità eccedente.... I palestinesi non sono l'unico popolo al mondo ad essere stato categorizzato in questo modo.... Lo scartare dal 25 al 60 per cento della popolazione è stato il marchio di fabbrica della crociata intrapresa dalla Scuola [di Economia] di Chicago.... In Sud Africa, in Russia e a New Orleans, i ricchi costruiscono intorno a sé dei muri. Israele ha condotto ancora più avanti questo processo di rifiuto: ha costruito muri intorno ai poveri pericolosi” (p. 442).I fatti israeliani sul terreno non sono altro che l'esprimere in modo fisico una linea che cerca di depoliticizzare, e quindi di normalizzare, il controllo esercitato. Lo scontro israelo-palestinese non è presentato come un conflitto che ha parti in causa ed una dinamica politica. È descritto, invece, come una “guerra al terrorismo”, una lotta con un fenomeno che elimina – o indica come irrilevante – ogni riferimento all'occupazione, che Israele ufficialmente nega di imporre. Dal momento che il “terrorismo”, con lo “scontro di civilizzazioni” che ne è alla base, è dipinto come un “dato” evidente e perpetuo, assume la forma di un problema che non è tale, di uno status quo (termine israeliano ufficiale per la sua politica verso i palestinesi), immune ad ogni soluzione e/o ad ogni processo negoziale. I “terroristi” e chi è a loro associato – carcerati, immigranti illegali, baraccati, poveri, le vittime malcontente della “repressione delle sommosse”, chi aderisce a religioni, ideologie o culture “malvagie”, per non citarne che alcuni – sono considerati come strutture fisse, da affrontare, anziché che come persone: se li si considerassero come esseri umani, si cercherebbero risposte ai loro reclami, alle loro necessità ed ai loro diritti. Una volta che si è scelto di affrontarli, la soluzione logica, e penultima, al problema globale divengono le prigioni, fra cui sono comprese le residenze coatte vaste come Gaza.“Tenere in stoccaggio” è l'espressione migliore, anche se la più cupa, per quanto Israele sta attuando per i palestinesi dei Territori Occupati. È qualcosa di peggiore, per diversi motivi, dei bantustan sudafricani dell'era dell'apartheid. Le dieci “patrie”, economicamente non autosufficienti, istituite dal Sud Africa per la maggioranza africana nera sullo 11 per cento soltanto del territorio del Paese erano, certo, un tipo di stoccaggio. Avevano lo scopo di fornire al Sud Africa manodopera a basso prezzo, liberandola della popolazione nera; questo rendeva possibile una “democrazia” dominata da europei. Questo è precisamente ciò a cui Israele mira - tramite un bantustan palestinese che comprende all'incirca il 15 per cento della Palestina storica -, ma con un limite cruciale: ai lavoratori palestinesi non sarà permesso recarsi in Israele. Avendo scoperto una manodopera più a buon mercato - circa 300mial lavoratori stranieri, importati da Cina, Filippine, Thailandia, Romania ed Africa Occidentale, con l'aggiunta dei propri cittadini arabi, mizrachi, etiopi, russi e dell'Europa dell'Est – Israele può permettersi di rinchiudere fuori i palestinesi, impedendo loro, nel contempo, di avere un'economia autosufficiente che sia la loro, legata senza ostacoli ai Paesi arabi circostanti. Da ogni punto di vista – storico, culturale, politico ed economico – i palestinesi sono stati definiti come una “umanità in sovrappiù”; l'unica cosa da fare con loro resta lo stoccarli, atto che la comunità internazionale, che se ne interessa, pare voler permettere ad Israele.Dal momento che lo stoccaggio è un problema globale, e che Israele ne presenta, pionieristicamente, un modello, quel che avviene ai palestinesi dovrebbe preoccupare chiunque. Potrebbe costituire un crimine interamente nuovo contro l'umanità, e come tale, dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione internazionale dei tribunali del mondo, così come lo sono altre gigantesche violazioni dei diritti umani. In questo senso, la “Occupazione” israeliana ha implicazioni che oltrepassano di gran lunga un conflitto localizzato fra due popoli. Se Israele può confezionare ed esportare la propria, pluristratificata, Matrice di Controllo – un sistema di repressione permanente, che combina un'amministrazione kafkiana, leggi e sistemi di pianificazione con forme apertamente coercitive di controllo su una popolazione definita, intrappolata da comunità chiuse ostili (in questo caso, le colonie), muri e ostacoli al movimento di vario tipo - allora, come scrive semplicemente la Klein, ogni Paese somiglierà ad Israele/Palestina: “Una parte sembra Israele; l'altra sembra Gaza”. In altre parole, una Palestina Globale.Questo contribuisce molto a spiegare perché Israele non si cura di intraprendere processi di pace genuini, o di risolvere il conflitto con i palestinesi. Stoccandoli, ottiene il meglio da entrambi i mondi: completa libertà di espandere le colonie e di esercitare il controllo, senza mai dover fare compromessi, come lo richiederebbe una soluzione politica. Questo, analogamente, spiega perché la comunità internazionale permetta ad Israele di farla franca. Anziché presentare alla comunità internazionale problemi spinosi che devono essere risolti – violazioni dei diritti umani, della legge internazionale e di ripetute risoluzioni dell'ONU, per tacere delle implicazioni del conflitto medesimo sulla politica e l'economia internazionale – è considerato invece come chi fornisce un servizio di gran valore: lo sviluppo di un modello con il quale le “popolazioni eccedenti”, ovunque, possono essere controllate, gestite e contenute.Israele, allora, è completamente sincronizzata alla logica, economica e militare, del capitalismo globale, e per questo la si premia generosamente. Il nostro errore, incoraggiato da termini come “conflitto”, “occupazione” e “apartheid”, è considerare il controllo israeliano dei palestinesi come un problema politico che si deve risolvere. Sarà invece “risolto” quando i palestinesi saranno fatti “scomparire” – esattamente come avveniva sotto i regimi militari, in America Latina. Dov Weisglass, l'architetto del “ritiro” da Gaza del governo Sharon, aveva detto qualcosa del genere, in un'intervista rivelatrice (“The Big Freeze”, Ha'aretz Magazine, 8 ottobre 2004):“Il piano di ritiro è il conservante del principio sequenziale. È la bottiglia di formaldeide in cui mettere la formula del presidente [che Israele può mantenere i “blocchi” di colonie, compresa la Grande Gerusalemme] in modo che si conservi per un tempo molto prolungato. Il ritiro è, nei fatti, formaldeide. Fornisce la quantità di formaldeide necessaria perché non ci sia un processo politico con i palestinesi”.Haaretz: “Sta sostenendo, quindi, che avete scambiato la strategia di un accordo ad interim a lungo termine, con quella di una situazione ad interim, sempre a lungo termine?”“L'espressione americana è: “parcheggiare in modo opportuno”. Il piano di ritiro rende possibile ad Israele di parcheggiare in modo opportuno, in una situazione ad interim che ci distanzia quanto più possibile dalla pressione politica. Legittima il nostro assunto, che non vi è processo negoziale, con i palestinesi. Si tratta della decisione di fare il minimo possibile, per mantenere la nostra situazione politica. La decisione si dimostra valida. Rende possibile agli americani andare dalla comunità internazionale, che è in fermento e ribolle, e dire loro: “Cosa volete.” In più, trasferisce l'iniziativa nelle nostre mani. Obbliga il mondo ad occuparsi della nostra idea, dello scenario che abbiamo scritto...”.“Tenere in stoccaggio” è il più netto dei concetti politici: rappresenta il de-politicizzare la repressione, il trasformare un problema politico di prim'ordine in un non-problema, in una situazione spiacevole ma inevitabile, di cui il miglior modo di occuparsi è mediante il soccorso, la carità ed i programmi umanitari, unitamente agli schemi per lo “sviluppo” economico. È un vicolo cieco, un “dato”, per il quale non vi è a disposizione alcun rimedio. Non è questo, evidentemente, il caso, e non possiamo lasciarlo presentare in questo modo. Il tenere in stoccaggio è una linea politica che sorge dagli interessi particolari dei più potenti. Che noi adoperiamo questa espressione, pertanto, dovrebbe mirare a “dare un nome alla cosa” per comprenderla, allo scopo di combatterla e sconfiggerla. Israele, di nuovo, fornisce un esempio istruttivo (e incoraggiante). Perché, malgrado il suo potere quasi illimitato e privo di alcun controllo su ogni elemento della vita palestinese – ciò che comprende il sostegno attivo degli USA, dell'Europa e di gran parte della comunità internazionale, fra cui alcuni regimi arabi e musulmani -, non è riuscita a rendere inamovibili ne' l'apartheid, ne' lo stoccaggio. La resistenza palestinese continua, con il sostegno di popoli arabi e del più vasto ambito musulmano, di settori significativi della società civile internazionale e del campo della pace, critico, di Israele. L'effetto destabilizzante del conflitto sul sistema internazionale non fa che crescere, ed è possibile che, alla fine, obblighi la comunità internazionale ad intervenire. Ne' gli israeliani, ne' gli americani (con la complicità europea) sono in grado, malgrado il loro potere soverchiante, di imporre a forza il risultato a cui ambiscono.Il termine “stoccare”, pertanto, pur riferendosi ad un fenomeno reale, ha anche il significato di preavvertire. Dobbiamo procedere nel nostro sforzo di far finire l'Occupazione israeliana, anche se questo significa, alla fine, creare una Palestina/Israele autentica, o una più ampia confederazione regionale, piuttosto che una soluzione di apartheid-con-due-stati o uno stoccaggio vero e proprio. Guardare alla Palestina come ad un microcosmo di una più vasta realtà globale di stoccaggio ci rende capaci di identificare in modo più efficace gli elementi che compaiono altrove e di comprendere il modello che Israele sviluppa, per opporvisi meglio. In ogni caso, il nostro linguaggio, e l'analisi che questo genera, devono non solo essere onesti e privi di inutili riguardi: devono anche mantenersi al corrente delle intenzioni politiche e dei “fatti sul terreno”, che si espandono sempre più rapidamente.Jeff Halper di " Osservatorio Iraq"























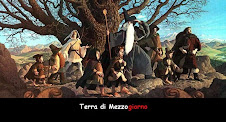











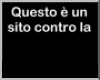




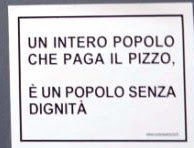
Nessun commento:
Posta un commento